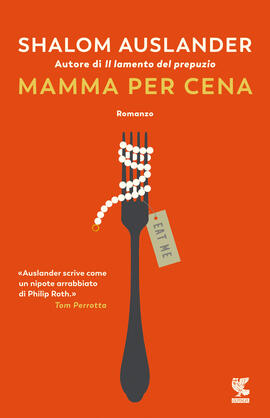- Ottieni link
- X
- Altre app
- Ottieni link
- X
- Altre app
L’esordio di Shalom Auslander è stato un po’ di anni fa. Il lamento del prepuzio è arrivato in Italia nel 2008, pubblicato da Guanda come il resto dei suoi libri. Ricordo che l’ho scelto in libreria a casaccio, il secondo anno di università, quando stavo a Milano, un’edizione economica che ai tempi doveva essere uscita da poco. Mi era piaciuto un sacco, ovviamente. Il racconto di questo ragazzo cresciuto in una famiglia ebraica praticante, il suo rifiuto della religione, dei suoi divieti, della famiglia che glieli ha imposti. Il continuo stringersi e dilatarsi della sua identità per farla entrare o scappare da involucri nuovi o vecchi. È passato un sacco di tempo dall’unica volta che l’ho letto, e quel poco che mi ricordo mi dà una sensazione di perenne instabilità, di disagio costante.
Poi ci sono stati Prove per un incendio (il protagonista scopre che Anne Frank si nasconde nella soffitta della casa che divide con la famiglia, compresa una suocera invadente) e la raccolta di racconti A Dio spiacendo (tra cui una ri-narrazione dei Peanuts in cui Snoopy diventa nazista). L’esperienza dell’ebreo americano è preponderante in tutta la sua produzione. Il conflitto con le tradizioni, con la storia. La supremazia dei genitori, il rapporto con la figura materna disfunzionale, tra attaccamento e apnea, e il conseguente senso di colpa. Va da sé che sono cose che si ritrovano anche in Mamma per cena, uscito nel 2022 nella traduzione di Elettra Caporello. D’altronde il titolo non lascia molto spazio per i dubbi.
La famiglia Seltzer, di cui fa parte il protagonista Settimo, stavolta non è ebrea. È Cannibale Americana. Una cultura (forse) antica, che si perde nei meandri della storia, perché nessuno si è premurato di scriverla. I Seltzer discendono da Julius e Julia, fratello e sorella che sono approdati a New York agli inizi del ‘900. Non è proprio chiaro da dove siano partiti. Non si capisce da dove abbia avuto origine la stirpe dei Cannibali. Lineamenti e incarnato sono vaghi, interpretabili a seconda dell’odio negli occhi di chi li guarda. Possono essere neri, israeliani, palestinesi, mediorientali. Si prestano a una pletora di pregiudizi diversi. Ma la minaccia vera, secondo Mamu – madre di ben dodici fratelli e sorelle, DODICI, perché Mamu voleva rinfoltire la stirpe Cannibale e si è messa d’impegno – è l’integrazione, l’omologazione al sogno americano. Mamu è un’invasata, ed è riuscita ad allontanare da sé e dalla cultura Cannibale la quasi totalità dei suoi figli. Anche Settimo l’ha tagliata fuori dalla sua vita, o almeno così ha cercato di fare. Abbandonato dallo psichiatra convinto che i suoi racconti sulla cultura Cannibale fossero baggianate inventate di sana pianta, Settimo riceve la chiamata della madre. Da tre anni si nutre solo di Big Whopper, anche una dozzina al giorno. Sente la fine vicina, e per quella fine intende ingrassare, da brava Cannibale. E arriva il momento in cui la fine è imminente e Settimo cede, mente alla moglie e torna nella casa della sua infanzia, rigonfia di fratelli e sorelle che non vede da una vita. Ognuno lontanissimo dagli altri. Il punto è che devono mangiarla, se vogliono la casa. Che trovandosi a Brooklyn, terreno di immensa gentrificazione, ormai vale una fortuna, pure divisa per dodici. Una situazione esacerbata dalla regressione in cui caschiamo quando torniamo a stretto contatto con la famiglia nucleare. A venti, trenta, quarant’anni, non ha importanza. Sei a cena coi tuoi, coi tuoi fratelli, e torni un adolescente capriccioso, un bambino che se la prende per un niente, perché la famiglia nucleare è la fonte primaria di tutto ciò che ci manca.
Il motore della trama è questo. Famiglie disfunzionali, eredità di sensi di colpa, di doveri che si sono sempre rifiutati ma che restano appiccicati come una colla corrosiva, la madre burattinaio. Ammetto che mi pungola, questa cosa, il fatto che la fonte di ogni male sia sempre la madre, mentre il padre, che pure se l’è svignata e non si è più fatto sentire, è la voce di una saggezza perduta, di una bontà che non viene messa in dubbio nonostante la scelta di sezionarsi. Ma comunque.
Il romanzo è rigonfio di altre cose. Di riflessioni sulla storia personale, sulle identità, sulle separazioni che operiamo tra noi e gli altri. Sull’omologazione, anche, sulla perdita che corrisponde ad essere altri da quello che sono stati i nostri genitori. Non posso dire di essere del tutto d’accordo con la visione di Auslander – o di Settimo? – riguardo alla minaccia dell’autodefinizione. Siamo tutti un incrocio di identità, che siano di etnia, di religione, di genere, di attrazione sessuale, di credo politico, e ognuna di queste identità definisce la nostra esperienza di individui. C’è poco da fare. Riconoscerlo, o proclamarlo, non corrisponde per forza a una cesura col resto. Ho l’impressione che qui Auslander metta in guardia contro gli eccessi di autodefinizione, nonostante la tematica di fondo di tutti i suoi libri gridi a pieni polmoni SONO EBREO e sprizzi esperienza ebraica.
(non riesco a non fare le pulci agli autori, andrebbe contro la mia identità di scassapalle, che non solo condono, ma rivendico).
Non vorrei però dare l’impressione che le pulci sopravanzino l’oggettiva figaggine del romanzo. Resta pieno di prospettive interessanti, di guizzi di assurdità che solo Auslander (c’entra pure Jack Nicholson), lo studio di una religione teorizzata nel dettaglio ed espressa nella vita dei Seltzer. È un libro di un certo spessore – letteralmente – ma l’ho finito in un giorno e mezzo, perché trascina. Eccome se trascina.
Dunque? Lo consiglio spassionatamente. Giusto un appunto sulla traduzione: qua e là vengono lasciati in inglese alcuni termini che per chi non conosce bene l’inglese possono risultare un ostacolo. Per dire, io Auslander lo regalerei a mio padre, ma al primo “background” gli tocca pigliare su il dizionario.
- Ottieni link
- X
- Altre app