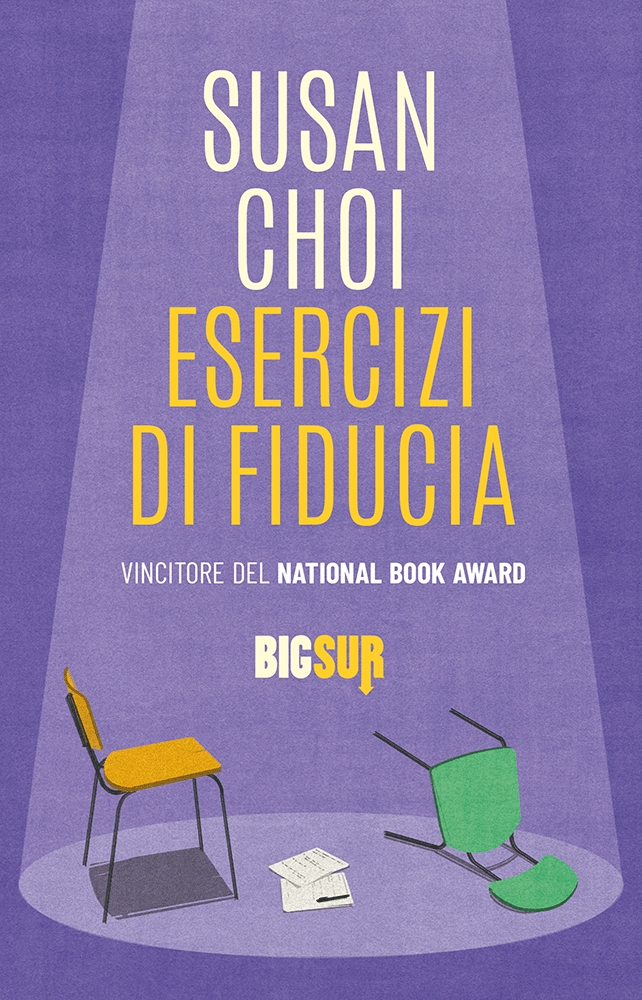- Ottieni link
- X
- Altre app
- Ottieni link
- X
- Altre app
Esercizi di fiducia di Susan Choi, uscito nel 2021 grazie ai tipi di Sur nella traduzione di Isabella Zani. Vincitore del National Booker Prize nel 2019. Prenotato in biblioteca su fiducia della casa editrice, che pubblica sempre cose buone. Le aspettative erano medio-alte, e devo dire che per le prime decine di pagine le vedevo disattese, mi chiedevo se il romanzo l’avrei poi finito o abbandonato. C’era qualcosa che mi teneva a distanza, qualcosa che avevo razionalizzato in una rappresentazione fredda dei protagonisti adolescenti. Mi pareva di vederli attraverso uno schermo, smorzati da una bolla. Assistevo ai loro colpi di testa, ai loro silenzi, ma non riuscivo a entrare. La distanza la interpretavo come una scrittura orba, un segno dell’incapacità dell’autrice di scrivere i giovani. L’adolescenza è un’età mitizzata, piena di peculiarità. Emotività a mille, pochi strumenti per placarla, ogni cosa è ingigantita, o forse la vediamo ingigantita noi adulti, schiacciati da problemi irrisolvibili, incapaci di dare il giusto peso alle cose che contano – l’amicizia, i sentimenti, le grandi domande su chi siamo e cosa vogliamo. Ultimamente mi capita di pensare a quanto sia ingiusto il mondo di regole ristrette in cui incateniamo i giovanissimi. Le gerarchie che esercitano un potere inevitabile, la capacità di controllo di sé e del contesto ridotta, le promesse così facilmente disattese. L’adolescenza ha regole tutte sue, ma questo non significa che gli adolescenti si debbano raccontare come un insondabile mistero. Sono individui a cui ogni tanto vorresti dire “ma anche meno”, ma pur sempre individui. Ed ecco, in Esercizi di fiducia faticavo a vederli come individui. Per un po’ mi sono sembrati solo sagome che si muovono in un certo modo, che sì, sentono qualcosa, e profondamente, ma del subbuglio vedi solo la superficie. E invece.
E invece il romanzo di Choi è pieno di filtri, di strati, più di un orco. Prima di tutto c’è un momento a metà in cui la voce narrante cambia, e scopri che quello che hai letto è… beh, non è tutto. Niente spoiler. La narrazione cambia, la prospettiva muta. E in questa stessa prospettiva, ci sono più prospettive. Entrambe più oneste. Vivide. Imbarazzate, consapevoli. La distanza scompare, e scopri che era un artificio, non solo, uno strumento, un crudo segnale da interpretare quando arrivi alla seconda parte della storia. Una carpiato così audace, così grandioso che mi ha esaltata. Mai stata così felice di non aver messo da parte un libro.
Ora, non voglio dare l’impressione che la prima parte fosse brutta. Non la era. Altrimenti l’avrei piantato e basta. Ma mi mancava un qualcosa, quel qualcosa. Il legame, ecco. E magari c’è chi quel legame con la prima parte lo sentirebbe eccome, non sono io a fare da tara. Ma dunque, la trama, che ancora non ne ho detto nulla.
Negli anni ‘80 c’è un istituto superiore per aspiranti attori. Oltre le materie normali – che nel romanzo non si fila nessuno – ci sono gli esercizi di fiducia del professor Kingsley, quelle di movimento con una docente di cui non mi ricordo il nome, e prove, prove, infinite prove per gli spettacoli da mettere in scena. La filosofia della scuola consiste nel metterti a nudo. Il professor Kingsley, in particolare, non si fa problemi a mettere in scena la situazione tesa tra Sarah e David, prima amanti e poi creature distanti e impaurite, incapaci di chiarirsi. La prima parte del romanzo è incentrata su Sarah, che vive con la madre che chissà perché tiene a distanza e lavora nei weekend in una panetteria perché vuole assolutamente potersi comprare una macchina allo scoccare dei sedici anni. Che ha già avuto esperienze sessuali poco significative, un’amica del cuore per un anno di cui si disfa emotivamente l’estate in cui sta con David. Sarah e il suo talento mediocre, il suo rapporto con la scuola, coi suoi sogni. È una voce esterna e fredda quella che ci parla di lei, cruda, se pensiamo alla sua età e il quotidiano orrore di quello che a un certo punto le capita, e che sembra riversarsi addosso perché si disprezza.
Dopodiché tutto cambia, e tutto acquista un senso. Ed è un senso che non viene spiattellato, ma suggerito. Perché a un certo punto non c’è davvero bisogno di spiegare, e se ci fosse bisogno di spiegare, potresti davvero capire? È più sottile, la seconda parte, non ti dice dove ha messo le risposte, e non si disturba di nascondertele.
Uno splendido esercizio di stile (sì, vorrebbe essere una mezza battuta, perdonatemi).
- Ottieni link
- X
- Altre app